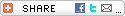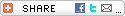Un fato capriccioso e crudele, che strazia personaggi in totale balia di sentimenti e passioni; una forza suprema che allontana i protagonisti nello spazio e nel tempo, per poi condurli a un inesorabile, cruento epilogo.
Accidenti, eventi funesti nella finzione e nella realtà, che, nel tempo, hanno trasformato La forza nel capolavoro jellato per eccellenza, insieme al Macbeth shakespeariano. Tutt'altro che sfortunata e accidentale è da considerarsi l'opera nell'ambito del percorso compositivo di Verdi: una svolta importante, conquistata non senza faticose tappe costellate da ripensamenti e collocata tra gli esiti geniali della Trilogia Popolare e la grandiosità dell'indiscussa Aida.
Principalmente innestato sul dramma Don ├ülvaro, o La fuerza del sino di Angel de Saavedra, duca di Rivas, il lavoro viene composto su libretto di Francesco Maria Piave per il Teatro Imperiale di Pietroburgo; il debutto russo del novembre 1862 è seguito da quello romano nel 1863. Diversi aspetti, però, non convincono il compositore, che decide di revisionare sotto vari punti di vista con l'apporto di Antonio Ghislanzoni: la prima scaligera della nuova versione avviene nel febbraio 1869, dando così il via alla vera diffusione dell'opera e al forte sodalizio di Verdi con il teatro milanese.
Il risultato della rielaborazione offre un componimento che va oltre gli stilemi del melodramma fino a quel momento concepito: i numeri chiusi divengono brani brevi e formalmente sciolti, in cui la musica definisce in modo più attento la psicologia di personaggi principali e non; si abbandona l'incontrastato primato della voce verso soluzioni che fanno dell'orchestra una vera e propria protagonista. Ciò è fortemente espresso sin dalla Sinfonia iniziale, oggetto primario della revisione operata da Verdi: quello che in principio era solo un breve Preludio diviene una pagina narrativa fondamentale e meravigliosa, in cui i temi musicali caratteristici delle varie vicende trovano sia espressione individuale sia completezza d'insieme. La magistrale direzione del Maestro Metha esalta tutte le caratteristiche di quella che può essere definita l'ultima Sinfonia del Cigno, muovendo colori e umori di un'Orchestra del Maggio in forma strepitosa. Tutto quello che La forza rappresenta è già contenuto, miscelato e sezionato, in questa pagina incredibile, facendo di ciò che segue una sorta di svolgimento visivo e uditivo di cui, in qualche modo, non si avverte la necessità.
La vicenda ha inizio con la realistica ricostruzione della dimora del Marchese di Calatrava (il basso Enrico Iori), in un salone dalle ricche pareti damascate, delimitato ai lati da porte con colonne e timpano, e in alto da un ricco fregio; cassapanche di legno scuro sullo sfondo, su cui sono posizionati candelabri che dispensano un'illuminazione soffusa e inquietante (le luci originali di J├╝rgen Hoffmann sono riprese da Luciano Roticiani), forse presagio dell'imminente tragedia.
L'accidentale uccisione del padre di Leonora (il soprano Violeta Urmara) da parte di Don Alvaro (il tenore Salvatore Licitra) e la conseguente sete di vendetta di Don Carlo (il baritono Roberto Frontali) proietta la narrazione in una dimensione da incubo: si tratti di Siviglia, Velletri o del convento, le strutture sono rovine distrutte, monoliti dal gusto primitivo, il tutto su uno sfondo di cielo e nuvole più o meno rarefatte (video e proiezioni di Sergio Metalli per Ideogramma, Rimini).
Il trio soprano-tenore-baritono, in quest'opera anomalo, dato che i due innamorati si incontrano solo all'inizio e alla fine, è ben svolto dagli interpreti, seppur Licitra tradisca una qualche difficoltà d'intonazione nell'arduo ingresso che Verdi riserva al personaggio di Don Alvaro. La dimensione spirituale è individuata dall'enorme mosaico di Cristo Pantocratore nel convento e dal vuoto rifugio eremitico, costituito da uno spaccato di cella su cui pende un enorme masso con una croce incisa: destino implacabile, presenza suprema di un Dio le cui volontà rifuggono la comprensione umana. Il basso Roberto Scandiuzzi e il baritono Roberto de Candia esprimono con efficacia l'austerità di Padre Guardiano e la buffa umanità di Fra Melitone.
Estrema cura è dedicata alle scene d'insieme, in cui il Coro del Maggio e Maggio Danza danno vita a variegate tipologie di personaggi intenti alle più disparate attività; in questo contesto si inserisce il bel personaggio di Preziosilla, interpretato con vivacità dall'interessante timbro del mezzosoprano Elena Maximova.
La messinscena scorre in modo complessivamente agevole, soprattutto grazie all'autorevole presenza di Metha, che disciplina con eleganza tempi e ritmi di questa impegnativa opera, per natura complessa in quanto a vicende e ambientazioni. |